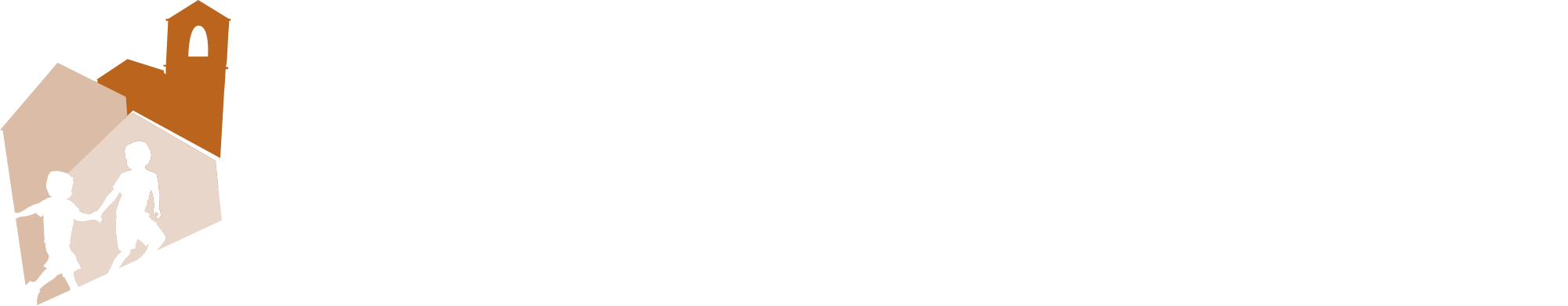“È antieconomico, diventa antisociale, persino un peccato di arroganza che qualcuno voglia continuare a vivere in montagna. Il problema del vivere in montagna è oggi, da un lato, immaginario/mitologico e può essere risolto, dall’altro economico burocratico e risulta insolvibile. Ci vorrebbe una terapia d’urto e ci offrono l’eutanasia assistita. (…). Le attività economiche sui monti dovrebbero essere considerate presidio geologico ed umanistico, una funzione sociale”.
Giovanni Lindo Ferretti (Cerreto Alpi)
È sufficiente ascoltare la voce dei territori per rendersi conto di come si stia alzando il livello di preoccupazione tra chi abita ed opera nell’Italia piccola, rurale e montana.
In Friuli, ad esempio, la Fondazione Think-Tank Nordest ha lanciato l’allarme ufficiale: 20 paesi rischiano di sparire entro 50 anni.*
“Il record negativo, tra i comuni più piccoli della regione, spetta a Claut. In 21 anni ha detto addio a 305 residenti. Nel 2001 in paese c’erano ancora 1.184 persone. Oggi gli abitanti sono solo 879. La tendenza non dà cenni di inversione. In mezzo secolo Claut sarà destinato a diventare un puntino invisibile sulla mappa del Friuli. Poco dopo, statisticamente, arriverà lo spopolamento definitivo. In provincia di Udine, Savogna (ai piedi del Matajur) nello stesso periodo ha perso 294 abitanti, passando da 662 a 348 residenti. In proporzione, il rischio è ancora più elevato: ci vorranno meno anni (circa venti) per fare del piccolo borgo un paese fantasma. Sono due casi isolati? No. Ci sono almeno venti paesi che in Friuli Venezia Giulia potrebbero non sopravvivere entro la fine del secolo in corso. Da Barcis a Cimolais, da Rigolato a Dogna: un’intera fascia della regione vede sempre più vicino lo spettro del fallimento demografico. E se Dogna dovesse perdere in 20 anni gli stessi residenti che sono mancati dal 2001 al 2022, sarebbe addio anche al comune più piccolo del Friuli (…). La provincia di Pordenone, ad esempio, rischia di perdere praticamente tutta la montagna. Dieci paesi: Claut, Cimolais, Barcis, Andreis, Castelnovo, Frisanco, Erto e Casso, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto. Sono passate amministrazioni regionali di tutti i colori politici.
Bandi, finanziamenti, soprattutto parole. Nessuno è riuscito a salvare la montagna friulana, che dove non c’è turismo di massa (lo sci, e poco altro) è sull’orlo del baratro”.
Oltre i numeri c’è la vita vera, le difficoltà quotidiane, i disagi e gli squilibri. E, come spesso accade, sono i sindaci a scattare la fotografia più efficace:
“Vent’anni di prese in giro – è il duro attacco di Gionata Sturam, sindaco di Claut -. Tanti incontri sulla montagna ma alla fine i soldi arrivano fino a Spilimbergo”. Che montagna non è. «Non vogliamo l’elemosina, ma le stesse opportunità di chi vive in altre zone – prosegue Sturam -. Un esempio? A Pordenone accendi il riscaldamento per 3-4 mesi l’anno e lo paghi meno. Da noi devi accenderlo per 8 mesi e spendi 7-8 mila euro. Ora vogliono metterci i contatori dell’acqua e farcela pagare di più: noi l’acqua la diamo a tutta la pianura, non devono farcela pagare. Per qualsiasi necessità dobbiamo andare fino a Maniago (quaranta minuti, quando va bene), la guardia medica quando c’è esiste solo dalle 20 alle 24. Abbiamo fatto una battaglia per un bancomat in paese. Ci sentiamo abbandonati e presi in giro». L’ultima battaglia? Quella per il gasolio scontato come avviene per i comuni vicini al confine con la Slovenia. Per ora un’altra partita persa. O forse nemmeno iniziata davvero. «Sono stato assessore nel 2001 – conclude Sturam con amarezza -: eravamo più di 1.200 in paese. Adesso siamo meno di 900. Diventeremo come Piancavallo, cioè vivi solo nella stagione turistica». Ma senza piste da sci”.
Cambiano gli accenti e i toponimi, ma non la sostanza. Così scendendo verso il centro Italia, nelle Marche, si possono leggere dati sostanzialmente simili:
“Aree interne Marche: Un Destino Da Cambiare. Dal 2013 al 2023 le aree interne delle Marche hanno perso oltre 5.000 attività economiche e più di 600 imprese manifatturiere. Questi territori stanno affrontando un calo demografico significativo (-7,8%) e un forte invecchiamento della popolazione (242 anziani ogni 100 giovani)”
Proseguendo in Basilicata, ho avuto la fortuna di conoscere Elisa di Giovanni del CNR Ismed, che ha condotto uno studio molto approfondito sulla realtà lucana:
“L’inverno demografico non accenna a placarsi. In Basilicata come nel resto del Mezzogiorno. Secondo una proiezione dell’ISTAT, nel 2066 i residenti lucani passerebbero da 570.157 a 399.164 unità, riportandoci indietro ai primi dell’800. Se non si riuscisse ad invertire questo trend, resisterebbero soltanto i sistemi urbani di Potenza, Matera, Vulture Melfese e Metapontino, con il resto del territorio svuotato. La situazione, dunque, è drammatica. Ecco perché il Piano strategico regionale si sviluppa, nelle sue diramazioni econo-miche e sociali, guardando sempre allo spopolamento, la prima emergenza da affrontare per mettere al riparo il futuro della Basilicata. L’obiettivo è creare le condizioni culturali e materiali per aiutare i lucani a crescere, formare una famiglia e realizzare le proprie aspirazioni nel territorio. Per poter agire in modo chirurgico è necessario conoscere a fondo il fenomeno. Di qui la decisione della Regione Basilicata di finanziare uno studio, nato dalla collaborazione tra Cnr Ismed (Istituto di studio sul Mediterraneo) e Università di Salerno (Dipartimento di Scienza Aziendali, Management & Innovation System), per andare oltre l’aspetto statistico della questione. Il vero tema è capire come arginare lo spopolamento individuando “best practice” in giro per l’Italia e l’Europa nell’ottica di replicarle in Basilicata”.
Continua la responsabile scientifica del progetto di ricerca:
“Il lavoro ha visto impegnato un team multidisciplinare nel dibattito scientifico specialistico ma al contempo inter/transdisciplinare dello spopolamento delle aree interne/marginali della Regione sulla scia di una armatura di politiche europee, nazionali, regionali atte a contrastare/mitigare l’impoverimento socio-economico-culturale-demografico con azioni mirate di rilancio territoriale. Le parole chiave del progetto si traducono, quindi, in: spopolamento, aree interne, Basilicata e quella veste di accezione “negativa” che riveste questi concetti si significa e tramuta in potenzialità nuove, generative, opportunità e volano di vantaggi per i territori. L’approccio integrato ha permesso di inquadrare la problematica oggetto di interesse da vari punti di vista: storico, economico e sociale, patrimonio culturale e turismo, mobilità, buone pratiche. I documenti regionali della Strategia territoriale ed il piano strategico 2021-2030 hanno costituito la guida del nostro lavoro, la base su cui innestare le nostre ricerche. Ricerche, che, come buoni ricercatori, sono partite da studi bibliografici e di archivio, ma che presto hanno virato sulla field research. Incontri con comunità ed amministrazioni locali, ascolto, dibattiti costruttivi con attori impegnati in prima persona in azioni di rigenerazione territoriale sono stati per noi linfa apportatrice di idee ed ispirazioni”.**
Numeri, esempi, studi e tentativi in giro, da Nord a Sud, attraverso un’Italia che non si arrende. Ma la sensazione (terribile) è che non si vada oltre. E che poi alla fine non succeda mai niente.
** https://www.lecronachelucane.it/2024/09/24/la-cura-contro-lo-spopolamento-delle-aree-interne/