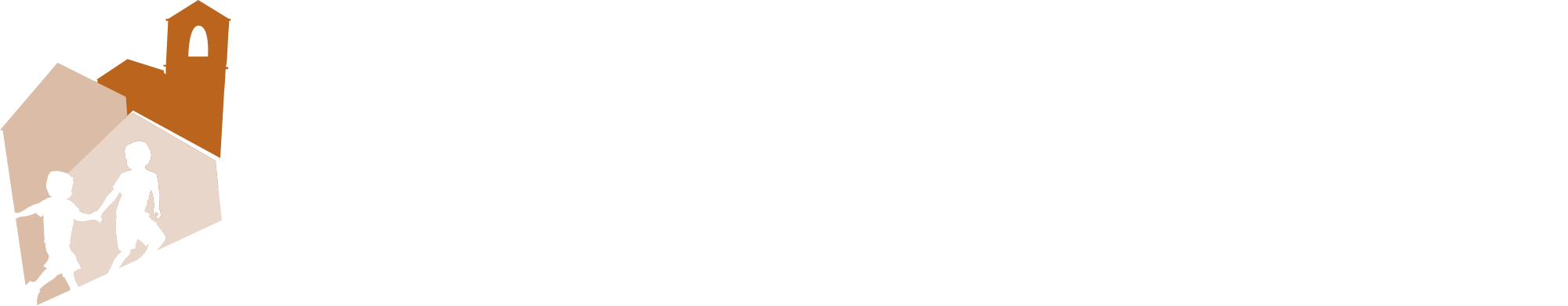“Italy is disappearing!”
Eleon Musk
Ben presto, quando ai numeri, ai problemi della maestra e alle operazioni in colonna subentrarono parentesi di ogni tipo, espressioni chilometriche e strutture algebriche sempre più incomprensibili, mi convinsi, per dirla con Antonello Venditti, che la matematica non sarebbe mai stato il mio mestiere. Niente di particolarmente grave, se non avessi scelto il Liceo Scientifico Ettore Onorato di Lucera come scuola superiore!
“Solo la sofferenza rende la vita sopportabile”, diceva santa Margherita Maria Alacoque, una specie di campionessa di masochismo e di automortificazioni corporali che evidentemente deve aver ispirato quella ed altre mie scelte non proprio confortevoli. Come quell’altra, ad esempio, che mi ha portato ad essere eletto Sindaco di Biccari, il mio piccolo paese, con la certezza che pur odiando numeri e matematica mi sarei ritrovato in un mare di calcoli, debiti, tagli e bilanci da far quadrare. Tutti i giorni.
Capirete, quindi, la mia pressocché totale idiosincrasia nei confronti di discipline come la statistica e ogni qualsiasi altra scienza che usa metodi matematici per analizzare fenomeni e tendenze collettive. Così come, mi auguro, comprenderete e perdonerete l’approccio estremamente semplificato a questa prima parte che, tuttavia, deve necessariamente partire dai numeri. Già, perché come diceva Lord Kevin già nel 1883 “se non siamo in grado di misurare qualcosa, non ne abbiamo una conoscenza soddisfacente”.
Ed allora, provo, con tutte le pinze di questo mondo, a prendere le misure con dati basici e spero intuitivi.
Partendo da quello che leggo.
È il 29 luglio 2024. Mentre cerco di godermi la mia prima vacanza con la famiglia senza il peso della fascia tricolore e il pensiero fisso alle cose da fare in paese, l’Istat pubblica un focus sulla demografia delle Aree interne.*
Tema caldissimo. Quasi come la temperatura. Tanto più che ho appena finito di leggere Vuoto a perdere di Marco Esposito (per Rubettino editore), un libro che, con l’efficacia di un pugno nello stomaco, parla del collasso demografico italiano e di come provare ad invertire la rotta.
“In base alla nuova mappatura relativa al ciclo di programmazione 2021-2027 della SNAI – recita il rapporto – le Aree interne comprendono oltre 4 mila Comuni, il 48,5% del totale. Si tratta di territori fragili nei quali i fenomeni demografici, come l’invecchiamento della popolazione e l’abbandono a causa delle migrazioni, sono esacerbati rispetto al resto del Paese e la cui analisi può essere d’ausilio come strumento di programmazione. Al 1° gennaio 2024, nelle Aree interne risiedono circa 13 milioni e 300 mila individui, circa un quarto della popolazione residente in Italia; nei Centri, invece, la popolazione è pari a 45 milioni e 700 mila individui. Dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2024 la popolazione residente nelle Aree interne è diminuita del 5,0% (da 14 milioni a 13 milioni e 300mila individui), mentre quella dei Centri dell’1,4% (da 46 milioni e 300mila a 45 milioni e 700mila)”.
“La perdita di popolazione nelle Aree interne del Mezzogiorno (-6,3%, -483mila individui) è più intensa rispetto a quella nelle Aree interne di Nord e Centro dove la diminuzione è, rispettivamente, del 2,7% e del 4,3% (oltre 100mila individui per entrambe). Nel Mezzogiorno, tra i Comuni in declino, oltre due terzi sono comuni delle Aree interne, mentre nel Centronord i comuni interni sono oltre un terzo (Prospetto 2). Se, quindi, nel Centro-nord, il calo demografico coinvolge quasi in egual misura i Comuni interni e quelli centrali, nel Mezzogiorno la diminuzione della popolazione riguarda per lo più Comuni appartenenti alle Aree interne e risulta, inoltre, più intensa rispetto a quanto accade per la stessa tipologia di Comuni nel Centro-nord”.
Tra le primissime cause di quello che Uncem ha definito il Deserto Italia** c’è naturalmente il calo delle nascite:
“Nei Comuni Periferici il tasso è passato, dal 2002 a oggi, da -1,5 a -6,3 per mille, mentre in quelli Ultraperiferici da -2,3 a -7,3 per mille, denotando una situazione nella quale il disequilibrio tra nascite e morti è più accentuato che altrove. Considerando l’intero periodo 2002-2023 il calo delle nascite è stato del 28,5% nei Centri e del 32,7% nelle Aree interne”.
Un altro importante elemento di fragilità demografica delle Aree interne è dovuto alle migrazioni verso le città o l’estero:
“Nel periodo dal 2002 al 2023 i tassi migratori totali (tassi interni più tassi con l’estero) delle Aree interne sono stati positivi, seppur contenuti, solo fino al 2011, grazie al contributo della forte pressione dell’immigrazione straniera che ha caratterizzato il primo decennio degli anni Duemila. Dal 2012 al 2019, invece, la stabilizzazione dell’immigrazione straniera su consistenze più moderate ha impedito il riequilibrio delle perdite di popolazione dovute alla mobilità in uscita dalle Aree interne”
Per un’idea più concreta di quello che sta succedendo, l’Istat sceglie un esempio plastico:
“Dal 2002 al 2023 si conta una perdita complessiva di 190mila residenti delle Aree interne, equivalenti alla scomparsa di una città come Taranto e quasi la metà delle partenze (46,2%) origina da Aree interne del Mezzogiorno, a conferma del fatto che la tradizionale traiettoria dal Sud verso il Nord continua a essere una delle principali direttrici della mobilità interna che interessa il Paese”.
Un altro fattore che incide sullo spopolamento delle Aree interne è costituito dai consistenti flussi di espatri dei cittadini italiani verso l’estero:
“A differenza dei Centri, le Aree interne, soprattutto nell’ultimo decennio, non sono attrattive per gli immigrati stranieri che scelgono di insediarsi più frequentemente nei grandi centri urbani dotati di servizi e, molto spesso, laddove risiedono altri concittadini appartenenti alle stesse comunità (effetto network). Il ridotto apporto della presenza straniera non permette di compensare adeguatamente i flussi di espatrio e, in combinazione con la bassa natalità, causa il diffuso declino demografico delle Aree interne”.
Completa il quadro a tinte fosche tracciato dall’Istat il dato sulla fuga dei giovani laureati:
“Negli ultimi 20 anni, il numero di giovani laureati italiani che dalle Aree interne si sono trasferiti verso i Centri o verso l’estero, è costantemente aumentato, mentre molto meno numerosi sono stati i flussi sulla traiettoria opposta. Tra il 2002 e il 2022 si sono complessivamente spostati dalle Aree interne verso i Centri poco meno di 330mila giovani laureati di 25-39 anni, mentre appena 45 mila verso l’estero. Nello stesso periodo, sono rientrati verso le Aree interne 198 mila giovani laureati dai Centri e 17mila dall’estero. Ne consegue che la perdita di capitale umano delle Aree interne è pari a 132 mila giovani risorse qualificate a favore dei Centri e di 28 mila a favore dei Paesi esteri. Complessivamente lo svantaggio per le Aree interne è pari a 160mila giovani laureati”.
L’inevitabile conseguenza è quella di Aree interne svuotate e anche più vecchie:
“Ancora una volta più fragili appaiono i Comuni Periferici e Ultraperiferici dove, al 1° gennaio 2024, ci sono, per 100 bambini al di sotto dei 15 anni, rispettivamente ben 225 e 243 anziani. I Comuni Periferici e Ultraperiferici mostrano livelli di invecchiamento ancora più elevati. La popolazione oltre i 65 anni costituisce infatti il 25,9% e il 26,8% nei Comuni, rispettivamente, Periferici e Ultraperiferici, mentre la fascia di popolazione al di sotto dei 15 anni è pari all’11,5% e all’11,0%”.
Se i dati attuali fanno paura, lo scenario di previsione tracciato dall’Istat è letteralmente da brividi:
“Le previsioni sul futuro demografico dell’Italia, aggiornate al 2023, confermano il declino della popolazione nel breve e medio periodo. Lo scenario di previsione “mediano” contempla un calo di popolazione da 59,0 milioni al 1° gennaio 2023 (anno base) a 58,2 milioni nel 2033 (-1,4%) sino a 56,5 milioni nel 2043 (-4,3% rispetto al 2023). La variazione sull’anno base, nel breve e nel medio periodo, risulta più accentuata per i Comuni delle Aree interne (rispettivamente -3,8% e -8,7%) rispetto ai Comuni dei Centri (-0,7% e –3,0%).Sulla base delle ipotesi formulate dalle recenti previsioni demografiche, tra 10 anni quasi il 90% dei Comuni delle Aree interne del Mezzogiorno subirà un calo demografico, con quote che raggiungeranno il 92,6% nei Comuni Ultraperiferici”.
Lo so, tutti questi numeri e percentuali messi in fila così, anche se assolutamente necessari, sono di una noia mortale.
Passiamo alle parole. Paolo Manfredi in L’Eccellenza non basta, un lavoro che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente durante una bellissima presentazione a Troia sui Monti Dauni, ricorda:
“la demografia non cambia solo la società e la geografia, ma anche le prospettive di crescita economica, intervenendo sul mercato del lavoro e sugli equilibri di welfare”.
Secondo il demografo Alessandro Rosina sta letteralmente cambiando tutto:
“la popolazione italiana è entrata da pochi anni in una nuova fase della sua storia, quella del declino demografico, che caratterizzerà tutto il resto di questo secolo. Il nostro Paese è attualmente quello che soffre il maggior declino demografico nell’Unione Europea, fenomeno aggravato dalla crescita intensa della popolazione anziana e dalla decrescita di quella giovanile”.***
Da quanto si è visto, poi, alle fragilità nazionali, si aggiungono quelle proprie dei piccoli comuni dove alla denatalità ormai tipica della società italiana (e non solo) si aggiungono gli effetti dello spopolamento. Una doppia debolezza. A dieci anni dall’avvio della Strategia nazionale per le aree interne la popolazione dei Comuni marginali è scesa mediamente del 5,0% con picchi anche del doppio nelle aree montane, più fragili, più periferiche. Il bilancio è negativo. Molto negativo.
Se si vuole uscire da questa specie di palude demografica in cui lentamente ma inesorabilmente si sprofonda sempre più in basso, tocca far qualcosa di diverso.
* La demografia nelle aree interne: dinamiche recenti e prospettive future, 29 luglio 2024, ISTAT.
*** Paolo Manfredi, L’Eccellenza non basta, Geca ed., 2023.